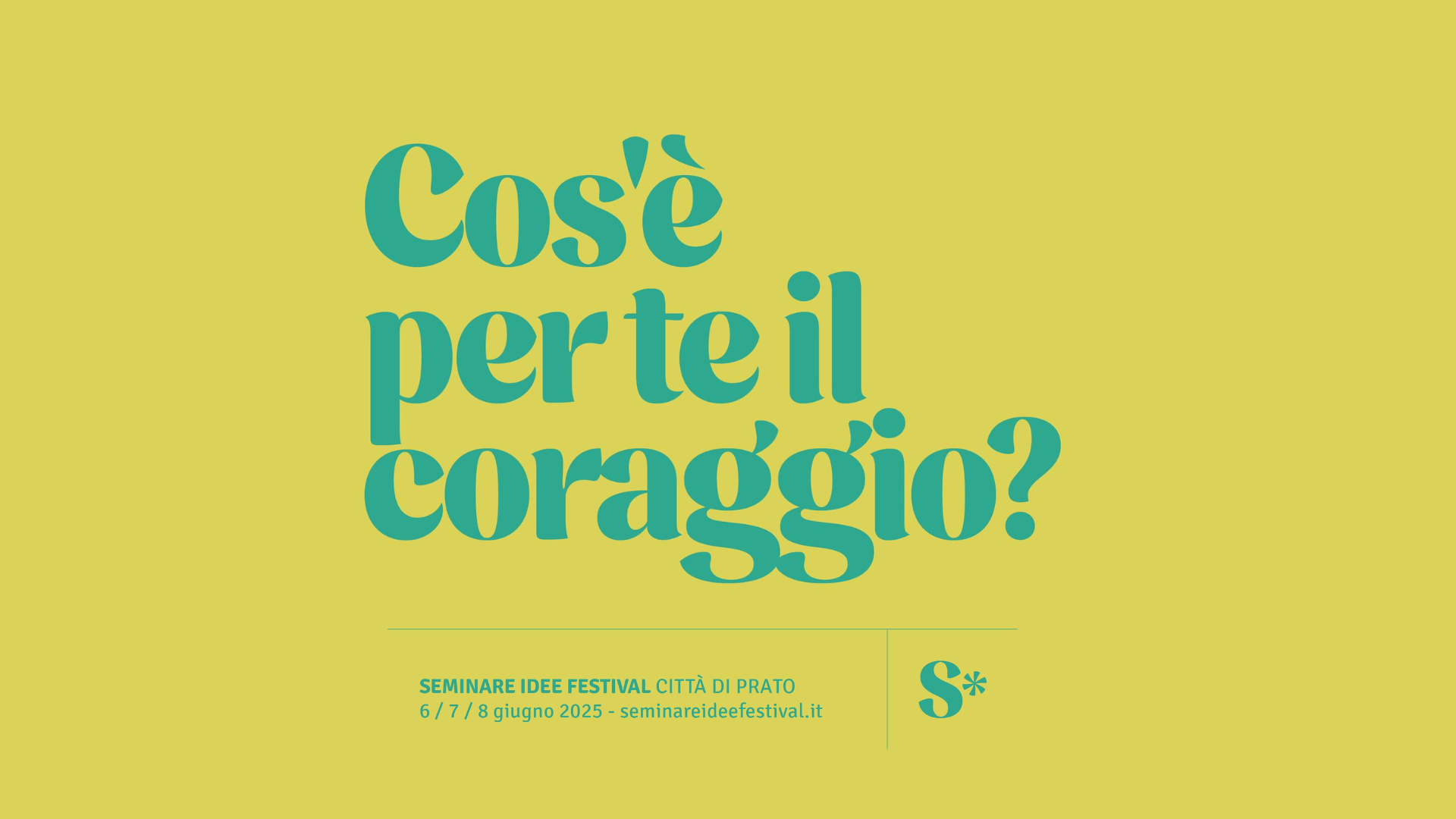Contributo di Diana Marta Toccafondi, Presidente delle Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
“Signori, chi ha qualcosa da dire, si faccia avanti e taccia!” scriveva provocatoriamente Karl Kraus nel 1914 in un testo dal titolo significativo e drammatico: Gli ultimi giorni dell’umanità. Davanti agli orrori della Prima Guerra mondiale, quello di Kraus non era un invito a tacere ma ad usare la parola in modo responsabile, a trovare il coraggio di guardare in faccia la realtà e dirla con parole adeguate, accuratamente pensate, rispettose della verità. Oppure a scegliere un consapevole silenzio, per non aumentare il rumore di fondo con un insensato chiacchiericcio.
Molti anni dopo, con analoga passione civile, Tiziano Terzani rilanciava lo stesso invito alla responsabilità collettiva, osservando dolorosamente che «abbiamo perso la misura di chi siamo, il senso di quanto fragile ed interconnesso sia il mondo in cui viviamo», e quindi di quanto forte sia la responsabilità di ciascuno verso tutti, anche e soprattutto nell’uso delle parole. Oggi, in un’epoca di profonda e inquieta trasformazione, l’eco di questi appelli risuona ancor più forte e carico di senso. Non possiamo non sentirlo.
Per sapere come raccogliere e rendere efficaci questi appelli nella realtà che rappresentiamo come Fondazioni di origine bancaria cominciamo da un’analisi di noi stessi nella dinamica evolutiva che ci ha finora caratterizzato. Nel corso della loro storia le Fondazioni hanno maturato un’attenzione specifica alle comunità, ai loro bisogni, ai loro linguaggi. Ne è derivata una sempre maggiore coscienza del proprio ruolo, che ha prodotto strategie operative spesso innovative, sia sotto il profilo dei temi individuati che delle metodologie adottate, caratterizzate da un costante sforzo a costruire collaborazioni, aggregazioni, reti di soggetti pubblici e privati. Soprattutto negli ultimi anni le Fondazioni hanno avuto un’evoluzione che le ha condotte ad essere non più realtà semplicemente erogatrici di contributi ma istituzioni coprotagoniste nella cura del futuro, soggetti attivi inseriti nella rete istituzionale che accompagnano e sostengono, anche con proprie progettualità, lo sviluppo delle comunità guardando con particolare attenzione alle contraddizioni e agli squilibri sociali, al disagio, ai gap culturali.
Nelle motivazioni del nostro agire siamo passati da una cultura dell’attenzione ai bisogni come elargizione graziosa e un po’ paternalista di risorse ai cosiddetti “meno fortunati” – secondo i due modelli storici che ci stanno alle spalle: quello della “beneficienza” ottocentesca d’ambito cattolico e quello della “filantropia” liberista d’ambito protestante – ad una attenzione reale e partecipe a ciò che tutti ci riguarda, sia sotto il profilo materiale che emotivo, sia nella dimensione privata che pubblica, sia in prospettiva locale che nella dimensione delle tante e diverse “comunità” che ormai convivono e popolano il variegato, largo orizzonte in cui ci muoviamo.
“Viviamo un tempo ambiguo in cui molte cose si chiudono, molte regole saltano, molte analisi falliscono, ma anche molte novità si fanno strada, sebbene in modo incerto nelle loro possibili conseguenze. Di questo tempo, che ancora non ha elaborato un modello alternativo a quelli precedenti, siamo tutti chiamati a disegnare la mappa.”
Consapevoli di questo percorso, di fronte alla epocale trasformazione che ormai coinvolge e più spesso travolge ogni quadrante del nostro tempo e del nostro spazio, occorre prendere coscienza del mutamento, non chiudersi in paradigmi difensivi, promuovere la nascita di nuove soluzioni anche fuori dagli schemi attingendo al grande patrimonio che ci fa umani, quello della mente e del cuore come si esprime nella cultura e nell’esperienza.
Viviamo un tempo ambiguo in cui molte cose si chiudono, molte regole saltano, molte analisi falliscono, ma anche molte novità si fanno strada, sebbene in modo incerto nelle loro possibili conseguenze. Di questo tempo, che ancora non ha elaborato un modello alternativo a quelli precedenti, siamo tutti chiamati a disegnare la mappa. Non spetta a noi immaginare nuovi modelli e forse non è neppure utile (non è più il tempo di modelli calati dall’alto) ma dobbiamo almeno cartografare il terreno per sapere come muoverci, come eventualmente ripensare il nostro ruolo e indirizzare la nostra azione futura, a partire da alcune delle cose che vediamo.
Tra queste, sicuramente balza agli occhi il disorientamento delle persone e soprattutto dei giovani, la difficoltà che deriva dal sentirsi oggetti e non soggetti della trasformazione, la fragilità del vivere una vita appesa al momento e che non vede futuro, la conflittualità e la competitività esasperata sia a livello individuale che generale, il ripiegamento egotico su se stessi, la perdita di senso e il senso della perdita. In ultimo – ma la collocherei tra i primi posti in una ipotetica gerarchia di importanza – salta agli occhi la difficoltà di dire la realtà con parole adeguate, di renderla intelligibile secondo percorsi di senso che non rispondano alla logica della retorica, dello slogan, della manipolazione delle opinioni per fini strumentali ma a quella della ricerca onesta di una o più possibili verità intorno a cui confrontarsi.
“Consapevoli di questo percorso, di fronte alla epocale trasformazione che ormai coinvolge e più spesso travolge ogni quadrante del nostro tempo e del nostro spazio, occorre prendere coscienza del mutamento, non chiudersi in paradigmi difensivi, promuovere la nascita di nuove soluzioni anche fuori dagli schemi attingendo al grande patrimonio che ci fa umani, quello della mente e del cuore come si esprime nella cultura e nell’esperienza.”
Ci vuole coraggio ad affrontare un tempo così senza cedere al richiamo delle sirene che proclamano la legge del più forte, del vincente ad ogni costo. In questo, la cultura è sicuramente uno strumento potente ma anche uno strumento delicato, non immune da rischi di cui dobbiamo tenere conto. Un rischio è, per esempio, quello di veicolare una visione in cui la cultura è un prodotto da consumare come i tanti che il mercato propone, un hobby, un divertissement senza contenuto reale o, peggio ancora, la stampella di un ambiguo richiamo identitario.
Ci vuole coraggio – ma credo che alle Fondazioni non manchi, come hanno dimostrato in passato – per operare una precisa scelta di campo, quella che punta sulla forza liberatoria con cui la cultura apre i nostri occhi e il nostro cuore, ci riconcilia con il tempo e lo spazio, ci apre ad altri tempi e ad altri spazi. In una parola: educa all’alterità, alla comprensione solidale, alla condivisione, facendo della cultura quello che alla fine è veramente: aria da respirare, tutti insieme.
Queste riflessioni sono all’origine di un progetto che stiamo promuovendo come Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, in collaborazione con il Comune di Prato. Si tratta della prima edizione di “Seminare idee – Festival città di Prato” che si svolgerà a Prato dal 6 all’8 giugno prossimi. L’intento è quello di prendere in carico queste tematiche con un’attenzione mirata alle fragilità e alle potenzialità di una città-mondo, fertile di presenze e di intelligenze diverse (più di cento etnie!), e di inventarsi una sorta di rito comune di “riparazione storica della parola” chiamando i giovani, le istituzioni, tutta la città a confrontarsi con i pensieri e le parole di coloro che sono invitati a parlare. Una “parola seminale” farà da filo rosso a tutti gli appuntamenti, favorendo uno sguardo trasversale alle discipline, la cui chiusura in linguaggi specialistici spesso refrattari all’inseminazione reciproca è uno dei problemi del nostro tempo. La parola seminale scelta per questa prima occasione sarà – non a caso – “coraggio”. Una parola che ha due possibili declinazioni: quella individuale e quella collettiva, quella dell’io e quella della comunità, ma soprattutto una parola che nel suo etimo contiene un richiamo al cuore (cor-habeo), in unità inscindibile con la mente. Perché seminare idee, alla fine, è atto preliminare al coltivare sentimenti.