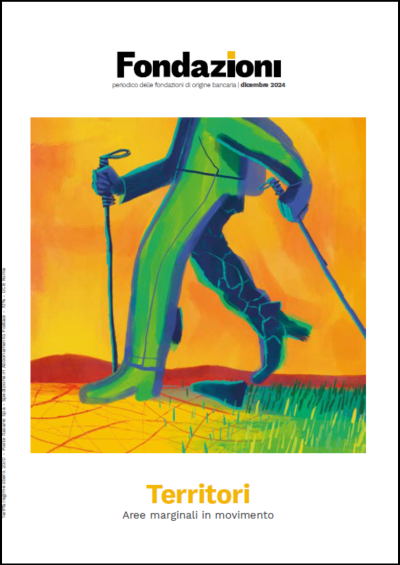Intervista a Rossella Moscarelli, ricercatrice al Politecnico di Milano
Rossella Moscarelli è ricercatrice al Politecnico di Milano presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, dove ha sviluppato una tesi di dottorato sulle aree interne italiane e la loro rigenerazione a partire da progetti di linee turistiche lente. Insegna Progettazione Urbana e collabora alle attività di ricerca del gruppo VENTO, in particolare studiando le politiche pubbliche che hanno permesso lo sviluppo territoriale legato a ciclovie o cammini come il Cammino di Santiago in Spagna. L’abbiamo intervistata.
Quando si parla di cammini o ciclovie, si citano spesso i concetti di marginalità e disuguaglianza territoriale. Ci può dare una definizione?
Non esiste una definizione univoca. Io ho aderito a un filone di pensiero che le associa a una relazione squilibrata tra territori, nella quale alcuni sono ritenuti subalterni ad altri. Attraverso questa lente di lettura, la marginalità non è considerata una condizione statica, quindi propria di un territorio, ma una condizione dinamica: un luogo non è svantaggiato per le proprie caratteristiche, ma lo diventa nella relazione di squilibrio con altri territori. In questo senso, la disuguaglianza territoriale, e di conseguenza anche sociale ed economica, si crea quando i territori non hanno gli stessi gradi di relazione tra loro (economica, politica, culturale, ecc.) e, quindi, gli stessi diritti e servizi a disposizione. Questo diventa uno dei motivi per cui chi vive nei luoghi più marginali è spesso costretto a spostarsi.
I cammini possono essere uno strumento valido per contrastarle?
I cammini possono essere uno strumento valido solo nella misura in cui rientrano in un progetto più ampio sul territorio, che contribuisca a mettere in relazione i luoghi. Questo è il punto: se la marginalità è frutto di relazioni squilibrate tra luoghi, allora tutti i progetti che possono generare relazioni di maggiore equilibrio possono contribuire a ridurre questo stato di isolamento, compresi i cammini. E il Cammino di Santiago ci dimostra che è possibile.
“Se la marginalità è frutto di relazioni squilibrate tra luoghi, allora tutti i progetti che possono generare relazioni di maggiore equilibrio possono contribuire a ridurre questo stato di isolamento, compresi i cammini”
In che modo lo dimostra?
Il Cammino di Santiago è stato promosso da un attore pubblico (principalmente la Comunità Autonoma della Galizia) che ha coinvolto tanti Comuni fornendo specifiche direttive da applicare poi su scala locale. I Comuni coinvolti hanno dunque iniziato a dialogare tra loro entrando a fare parte di un progetto molto più ampio, che supera i confini amministrativi. È in questo modo che la scala locale si è dilatata senza essere omologata: tutti i Comuni, grandi e piccoli, che sono attraversati dal Cammino, fanno parte di un territorio lineare, con un’identità unica. Questa appartenenza ha portato ad alimentare relazioni tra amministrazioni ed enti locali e sovralocali, tanto su questioni legate strettamente allo sviluppo turistico, quanto sulla gestione ordinaria del territorio di cui tutti i Comuni si sentono parte. Come per quelli del Cammino di Santiago, anche i nostri Comuni più piccoli e fragili possono avere difficoltà di pianificazione e di gestione amministrativa, facendo fatica a immaginare strategie di futuro ambiziose rimanendo dentro i propri confini locali. La pianificazione lineare, legata cioè a un cammino, invece, permette loro di vedersi dentro una dimensione più ampia, con una visione veramente strategica, anche grazie a un coordinamento sovralocale.
Attivando un cammino, questo esito è automatico?
Non è automatico, ci deve essere al principio un’intenzionalità a instaurare e mantenere questo tipo di relazioni tra i territori, investendo cospicue risorse nella progettualità e aprendo tavoli di dialogo permanenti. Solo in questo modo un cammino può rappresentare un’opportunità e continuare a dare frutti nel tempo. In poche parole, non è sufficiente creare una mappa turistica che indichi il cammino e le tappe, ma è necessaria una dimensione infrastrutturale che renda possibile l’esistenza del cammino, ridisegnando e ripianificando tutto il territorio in prossimità, affinché ritrovi la propria identità o ne costruisca una nuova.
“In Italia, si è persa l’occasione di creare una cabina di regia territoriale che potesse tenere insieme sia le questioni legate al turismo lento che quelle legate alla rigenerazione delle aree marginali e alla cooperazione amministrativa”
In Italia, esistono cammini che hanno attivato questo processo?
In Italia è avvenuto, ma solo in parte, con la Via Francigena. Ci sono sicuramente stati importanti investimenti da parte della regione Toscana: in circa dieci anni (grazie al Piano Operativo lanciato nel 2012) l’infrastruttura è stata realizzata, ma in un’ottica legata puramente allo sviluppo turistico. A parte per il finanziamento dell’infrastruttura, gestito dalla Regione Toscana, il processo di progettazione, realizzazione e di successiva gestione del cammino è rimasto in mano ai Comuni e alle associazioni legate alla promozione della Via Francigena, provocando una grande frammentazione e discontinuità delle azioni. Si è persa l’occasione di creare una cabina di regia territoriale che potesse tenere insieme sia le questioni legate al turismo lento che quelle legate alla rigenerazione delle aree marginali e alla cooperazione amministrativa. Oltre alla pianificazione e alla gestione amministrativa, la Via Francigena ha una dimensione identitaria, storica e territoriale talmente importante che non può essere demandata ai progetti dei singoli Comuni.
Ritorniamo dunque al tema della relazione tra territori.
Sì, perché un cammino può mettere in dialogo e in rapporto di cooperazione Comuni che non avrebbero mai avuto modo di dialogare perché appartenenti a diverse regioni o perché di differente dimensione e rilevanza. E non si tratta di questioni banali ma, in termini pratici, questo permette ai piccoli Comuni di contribuire in maniera proporzionale ad ampi progetti con prospettive strutturali e di lungo periodo e, parallelamente di redistribuire l’attrattività turistica, e dunque economica. I progetti legati ai cammini devono però essere riempiti di significato comprendendo che si tratta di importanti infrastrutture per i territori, e non solo di percorsi turistici attrattivi perché green, sostenibili e dal gusto alternativo. Solo così potremmo sfruttare le potenzialità degli strumenti della linea e della lentezza come i cammini e le ciclovie, che in questo paese sono tanti e capillari. E non solo, potremmo anche dare una dimensione pedagogica al cammino.
“L’incontro con i viaggiatori diventa quindi l’occasione di conoscere persone di tutto il mondo uscendo così dall’isolamento, che non è solo spaziale ma anche culturale”
Che significa dare una dimensione pedagogica al cammino?
Il turismo lento dà la possibilità di non guardare il viaggiatore come un consumatore e dunque di non trasformare il turismo in un’altra forma di consumo che risponde a logiche di profitto, con progetti disegnati e targhettizzati solo per il viaggiatore-consumatore. Il turismo lento, se attinge in maniera autentica ai valori della lentezza come pratica alternativa di abitare i luoghi (anche solo per il tempo di un viaggio), permette di osservare il viaggiatore come un cittadino e quindi far diventare una linea turistica anche un progetto di relazione con il territorio. E questa relazione è biunivoca: non è solo il viaggiatore a entrare in relazione con il territorio e scoprirlo ma anche il contrario. Questa visione porta a progettare servizi il più possibili ibridi, che siano utili non solo ad uso turistico ma anche per gli abitanti e ad avviare occasioni di relazione tra chi vive quei luoghi tutti i giorni e il viaggiatore occasionale, che possono anche aiutare a contrastare l’isolamento di alcune aree.
Può approfondire quest’ultimo punto?
Faccio un esempio. Le persone che abitano in un piccolo paese con 2mila abitanti si trovano spesso “tagliate fuori dal mondo”. L’incontro con i viaggiatori diventa quindi l’occasione di conoscere persone di tutto il mondo uscendo così dall’isolamento, che non è solo spaziale ma anche culturale. Prendere parte a un progetto come il Cammino di Santiago significa dunque uscire dalla dimensione “piccola” della marginalità ed entrare in contatto con il mondo sentendosi parte di qualcosa di importante, e con orgoglio.
Dalla rivista Fondazioni settembre – dicembre 2024