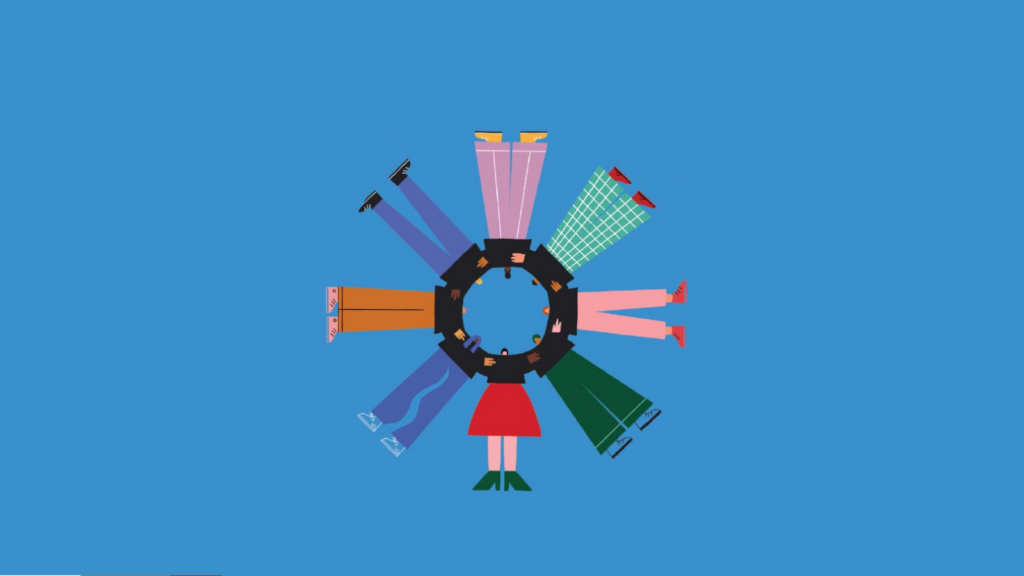Il termine disabilità è ancora presente nell’immaginario collettivo come qualcosa di “mancante”, di “diverso”. A questo immaginario ha anche contribuito la parola stessa che ha una etimologia complessa dal punto di vista semantico; si tratta di una parola composta di due parti, il prefisso verbale e nominale “dis” (dal latino) che rovescia il senso buono o positivo della parola a cui si prefigge che in questo caso è “abilità”, che indica la capacità di compiere una determinata attività. Dunque, dis-abilità letteralmente assume il significato di “mancata abilità”.
In realtà, all’utilizzo del termine “disabilità” si è giunti nel 1999 quando l’OMS decise di accantonare dai documenti ufficiali il termine “handicap”, che si riferiva più nello specifico a un impedimento, a menomazione fisica e psicologica, per introdurre quello di “disabilità” in un’accezione nuova, ovvero: “la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo”. Quindi, l’adozione del termine “disabilità” mette in evidenza come lo svantaggio non sia una caratteristica della persona, ma un problema che nasce dal rapporto tra lo stato di salute dell’individuo e l’ambiente in cui vive. Secondo questo punto di vista, è la società a rendere la persona disabile “diversa” dagli altri, non è la persona ad esserlo.
L’individuo sente la sua “disabilità” quando la società lo pone davanti ad un ostacolo che lo rende “emarginato”: salire una rampa di scale con una sedia a rotelle per esempio, oppure dover leggere una segnaletica stradale senza poter vedere, questi sono tutti esempi che “ricordano” alla persona disabile di vivere in una società strutturata per la maggior parte delle persone, ma non per tutte. Come può essere affrontato il problema dell’emarginazione sociale della persona disabile? Integrare la persona disabile nella società non significa soltanto inserirla nelle strutture e nelle attività, ma dargli la possibilità di partecipare e vivere con gli altri le stesse esperienze sia pure con modalità proprie.
Questo principio è chiaramente ribadito anche all’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Questo vuol dire che se una persona ha una disabilità che ne limita l’autosufficienza, ha gli stessi diritti di qualsiasi altro individuo e lo Stato deve adottare misure volte a rimuovere ogni impedimento che ostacoli l’uguaglianza.
È per perseguire questo obiettivo che le Fondazioni di origine bancaria promuovono e sostengono progetti di assistenza sociale rivolti in favore dei soggetti più fragili. Progetti che si basano su un preciso modello partecipativo che si propone di coinvolgere l’intera cittadinanza nella produzione o nel miglioramento di beni e servizi territoriali che possano garantire pari diritti, inclusione e partecipazione uguale per tutti. Nello svolgere questa attività le Fondazioni promuovono il modello del “welfare di comunità” che prevede l’adozione di pratiche di progettazione partecipata in cui i decisori politici incontrano i cittadini e costruiscono insieme cambiamenti, progetti, servizi di pubblica utilità. Questa attivazione comunitaria contribuisce a creare un paradigma che trasforma la considerazione delle persone più fragili da meri soggetti portatori di bisogni, a risorse utili a trasformare in meglio la propria vita ma anche quella l’intera comunità, a patto però che l’ambiente in cui si vive sia inclusivo e “alla portata” di tutti.
Per scaricare la rivista clicca qui o sull’immagine in basso